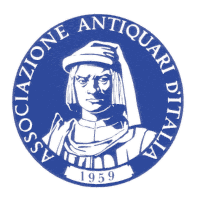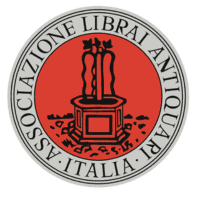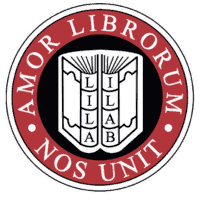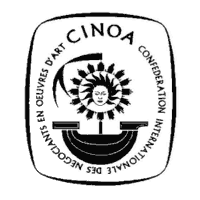Teodoro Matteini
Further images
-
(View a larger image of thumbnail 1
)

-
(View a larger image of thumbnail 2
)

-
(View a larger image of thumbnail 3
)

-
(View a larger image of thumbnail 4
)

-
(View a larger image of thumbnail 5
)

-
(View a larger image of thumbnail 6
)

-
(View a larger image of thumbnail 7
)

-
(View a larger image of thumbnail 8
)

-
(View a larger image of thumbnail 9
)

-
(View a larger image of thumbnail 10
)

-
(View a larger image of thumbnail 11
)

-
(View a larger image of thumbnail 12
)

-
(View a larger image of thumbnail 13
)

-
(View a larger image of thumbnail 14
)

-
(View a larger image of thumbnail 15
)

-
(View a larger image of thumbnail 16
)

-
(View a larger image of thumbnail 17
)

Il corpus di disegni qui descritto, oltre a rappresentare una significativa aggiunta alla produzione grafica di Teodoro Matteini, assume un ulteriore particolare interesse perché legato all’esordio nella pratica incisoria da parte dell’artista che qui si cimenta nella traduzione in immagini dei versi più significativi de “La Pronea”, il poema encomiastico che Melchiorre Cesarotti dedicò a Napoleone e alla sua epopea[1].
L’impresa di Matteini nel suo dispiegarsi si trasforma in un eccezionale affresco del periodo neoclassico veneto coinvolgendo i suoi più grandi protagonisti in un fitto intreccio tra arte e letteratura sotto l’egida dei potenti mecenati padovani De Lazara. Fu proprio il protettore dell’artista Giovanni de Lazara ad incoraggiare l’incontro del pittore con Cesarotti che fu suggellato dall’esecuzione da parte di Matteini del famoso ritratto del poeta poi inciso dal Rosaspina. Una consuetudine, quella tra il pittore e il letterato, che si andò consolidando nel tempo, come dimostra la scelta per il battesimo nell’arte dell’incisione caduta proprio su un’opera del Cesarotti e l’attiva partecipazione di quest’ultimo nella definizione dei soggetti dei disegni preparatori[2] (soltanto uno dei nove fogli qui presentati fu escluso dalla selezione per la stampa).
Matteini adottò un “tipo di disegno che, privilegiando la forza astraente più funzionale e più pura del contorno, definisce nella sua essenzialità l’immagine in uno spazio prospettico e bidimensionale”[3] riscoprendo i Primitivi. Alla maniera di Flaxman e Sabatelli, adeguò uno stile in realtà modernissimo al racconto dell’attualità delle imprese napoleoniche.
Nella fase successiva, che coincide con il delicato passaggio del trasferimento dei disegni sulla lastra, entra in scena nella vicenda Antonio Canova a cui l’artista toscano si rivolge per ricevere preziosi consigli riguardo allo stile e alla tecnica incisoria. Ne nasce un fitto carteggio in cui Canova si mostra molto disponibile nei confronti dell’amico pur non risparmiando critiche talvolta aspre che Matteini incassa con umiltà, desideroso di carpire i segreti del nuovo mezzo espressivo (per il carteggio si veda N. Gori Bucci, Il pittore Teodoro Matteini (1754-1831), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2006, p. 116-118, per l’opera in generale Ibidem, pp. 272-273).
La raccolta di incisioni, che porta la data del 1808, ed è molto rara a trovarsi completa delle 24 tavole, esprime l’erudizione del Cesarotti, l’abilità nel disegno di Matteini e la supervisione di Canova, risultando una sorta di manifesto del neoclassicismo veneto.
[1] “Il componimento poetico di Melchiorre Cesarotti, l’ultimo di una carriera umanistica di respiro europeo, è il resoconto degli eventi coevi, dall’esordio di Napoleone alla pace di Tilsit, strutturato come visione rivelatrice, sul modello della moderna letteratura visionaria. Il poeta senex mette in carta il dettato immaginario di Pronea (Πρόνοια, ‘provvidenza’ e ‘previdenza’) privilegiando una rilettura della storia in chiave provvidenzialistica: con l’occhio alla tradizione termidoriana francese, gli eventi dell’Ottantanove e lo spargimento di sangue che ne è conseguito diventano momento contingente di martirio collettivo funzionale alla redenzione sociale e politica per opera di Napoleone” (S. Puggioni, Per l’edizione della “Pronea” di Cesarotti, in “I cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo”, Roma, Adi editore, 2016.
[2] “L’invenzione dei quadri fu dall’autore concertata con me: io n’ho veduto alcuni abbozzi che mi parvero felici (…)” (Dell’Epistolario di Melchiorre Cesarotti, Pisa, Niccolò Capurro, 1813, Tomo IV, p. 119.
[3] N. Gori Bucci, Il pittore Teodoro Matteini (1754-1831), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2006, p. 115.
Iscriviti alla newsletter di Orsini arte e libri
* campi obbligatori
Tratteremo i dati personali che hai fornito in conformità con la nostra informativa sulla privacy (che trovi linkata nel footer). Puoi annullare l'iscrizione o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sul link presente nelle nostre email.