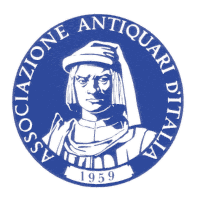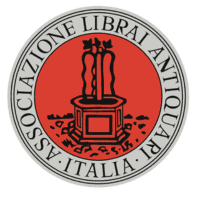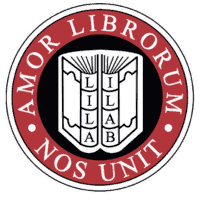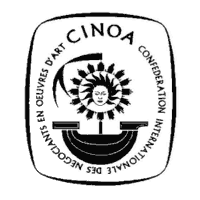-
Opere
Pietro Narducci
Ritratto di Tomaso Giuseppe Maria de Cristoforis con i figli Giuseppe e Vitaliano e il busto della moglie Maria Giuseppina Piantanida, 1831Olio su tela181x143 cmPietro Narducci presentò questo dipinto all’Esposizione annuale di Brera nel 1831, insieme ad altri sei ritratti. Negli Atti dell’Accademia di quell’anno è così descritto: “Ritratti a olio di una famiglia...Pietro Narducci presentò questo dipinto all’Esposizione annuale di Brera nel 1831, insieme ad altri sei ritratti. Negli Atti dell’Accademia di quell’anno è così descritto: “Ritratti a olio di una famiglia composta di un padre e due fanciulli contemplanti un busto femminile in marmo, per commissione del signor Don Tomaso De Cristoforis, eseguiti dal signor Pietro Narducci” (Atti dell’I.R. Accademia…, Milano 1831, p. 62).
L’identità dei ritrattati è svelata da un antico cartiglio applicato sul retro della cornice. E’ dunque lo stesso committente del dipinto, Don Tomaso De Cristoforis, a posare insieme ai due figli Giuseppe e Vitaliano e al busto della moglie Maria Giuseppina Piantanida, ritratta, come si legge sulla nota manoscritta, all’età di 24 anni.
Il dipinto attrae l’occhio del più famoso critico dell’epoca, Ignazio Fumagalli, che nella “Biblioteca Italiana” del 1831, spende per l’opera parole di elogio: “Tra i ritratti da lui (Pietro Narducci) esibiti il primo luogo daremo a quello graziosamente composto che rappresentava un padre e due figli dinanzi a un busto femminile: oltre la somiglianza ti allettavano specialmente le attitudini amorose di due fanciulli che ti parevano contemplare con aria di volto melanconica l’effigie dell’estinta genitrice”. (tomo 64, pp. 114-115)
Tomaso De Cristoforis nacque nel 1793, anno in cui il padre Luigi Maria fu dichiarato nobile con tutta la discendenza con diploma imperiale del 1° maggio. Dopo un’onorata carriera militare lasciò l’esercito nel 1816 con il grado di capitano d’artiglieria e si ritirò a Turbigo, piccolo borgo della Valle del Ticino, a gestire i suoi possedimenti dopo aver acquisito le proprietà dei Piatti, altra nobile famiglia della zona. Tra i beni entrati in possesso di Tomaso c’è anche il Palazzo de Cristoforis, nel cui parco con ogni probabilità è ambientato il ritratto. Dopo aver sposato Giuseppina Piantanida, rampolla di un’altra storica casata milanese, Tomaso acquisì anche i titoli e le armi gentilizie dei Piantanida grazie alla concessione del suocero, il marchese Gerolamo Piantanida di Cuggiono Minore, che, privo di prole maschile, voleva conservare il lustro del proprio nome, e mediante un atto notarile del 1° maggio 1824, adottò per figlio il genero Tomaso, rendendo ufficiale la transizione. Nel 1841 Tomaso de Cristoforis divenne tutore delle nipoti Flavia e Giuseppina, figlie del compianto fratello Giuseppe, personaggio molto importante per la città di Milano, avendo con il lascito della sua ricca collezione di manoscritti e opere a stampa relativa alle scienze naturali e la notevole raccolta di fossili, di minerali e di campioni vegetali e animali, a cui aveva dedicato gran parte della sua vita, posto le basi per l'istituzione del Museo civico di storia naturale, di cui la famiglia De Cristoforis conserva tuttora il diritto a discutere la nomina del conservatore. Altri milanesi illustri sono i cugini di Tomaso, Giovanni Battista, grande amico di Manzoni e Tommaso Grossi, Vitaliano e Luigi, noti per aver finanziato la costruzione della Galleria De Cristoforis, una delle prime architetture italiane in ferro e vetro, per dare a Milano "un luogo coperto che servir dovesse di pubblico ridotto nei tempi piovosi e generalmente nelle lunghe sere d'inverno". Patriota convinto, Tomaso indossò di nuovo l’uniforme per partecipare alle Cinque Giornate di Milano, chiamato dal Comitato di difesa pubblica milanese a coadiuvare il cavalier Stampa. Più in generale, la famiglia de Cristoforis si distinse per un certo diffuso spirito risorgimentale. Anche Carlo, nipote di Tomaso, fu capitano dei Cacciatori delle Alpi, partecipò all’insurrezione meneghina e cadde eroicamente a San Fermo. Il fervore patriottico doveva essere insito in Tomaso ben prima dei moti del ’48, come si evince focalizzando l’attenzione sulla foggia degli abiti indossati dai figli nel nostro dipinto, vestiti all’orientale come due “piccoli Byron”, forse veicoli di un messaggio di adesione alla causa dei patrioti greci, allora impegnati nella lotta per l’indipendenza dal dominio ottomano.
L’autore del dipinto è Pietro Narducci, abile e longevo ritrattista tra i prediletti dall’alta borghesia meneghina. Allievo di Luigi Sabatelli all’Accademia di Brera, a partire dal 1808 vince numerosi premi esordendo nel 1817 alle esposizioni annuali con una copia di un disegno da Luini. A partire dal 1819 partecipa con regolarità alle mostre braidensi presentando soprattutto ritratti insieme a soggetti legati alla pittura di storia. Tra i notabili milanesi da lui ritratti si ricordano Pietro Lampugnani, l’astronomo Barnaba Oriani, Ermes Visconti, Luigi Marchesi, Angelo Carlo Borsani, Leopoldo Schiaffinati, Costantino Perego, Carlo Castelfranchi. Diviene Socio di Brera prima di essere nominato professore alla scuola di pittura dell’Accademia Carrara di Bergamo. Si trasferisce poi a Vercelli terminando la propria carriera accademica all’Istituto d’arte. Dopo il 1860 torna alle esposizioni braidensi, presentando opere d’ispirazione romantica (“Ruggero e le ancelle di Alcina”, esposto a Firenze nel 1861, insieme a due soggetti sacri.
Nel nostro dipinto, che si può iscrivere alla tipologia del Conversation piece, come chiamano gli inglesi, grandi amanti del genere, che raffigura due o più persone, inserite in un ambiente che li rappresenta, spesso appartenenti alla stessa famiglia, mentre conversano, o meglio “comunicano” tra loro in maniera informale, Narducci riesce con un’efficacia tutta romantica a rappresentare la realtà dei sentimenti, riscoprendo a distanza di secoli la lezione lombarda del Luini e del Moroni, aggiornandola secondo una tecnica di ascendenza hayeziana, basata sulla nettezza grafica dei contorni, sulla solidità e l’equilibrio dei volumi e sull’alternanza tonale dei colori, ottenuta con l’accostamento di impasti puri e velature nette.
MOSTRE
Milano, Esposizione di Brera, 1831Literature
Mostra dei Maestri di Brera, Milano 1975, pp. 250-2518di 16
Iscriviti alla newsletter di Orsini arte e libri
* campi obbligatori
Tratteremo i dati personali che hai fornito in conformità con la nostra informativa sulla privacy (che trovi linkata nel footer). Puoi annullare l'iscrizione o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sul link presente nelle nostre email.