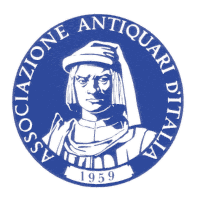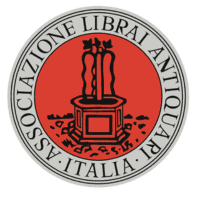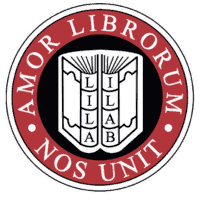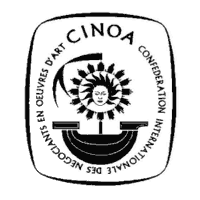-
Opere
Antonio Gualdi
Ritratto di Tommaso Minardi con il teschio, 1827Olio su tela83x62,5 cmFirmato e datato in basso a destra: “Antonio Gualdi 1827”
Quel giovane “sentimentale e dolente […] alla deriva sul suo materasso” come lo descrive Anna Ottani Cavina nel celeberrimo Autoritratto (Firenze, Gallerie degli Uffizi), trascorsi quasi quindici anni, è diventato...Quel giovane “sentimentale e dolente […] alla deriva sul suo materasso” come lo descrive Anna Ottani Cavina nel celeberrimo Autoritratto (Firenze, Gallerie degli Uffizi), trascorsi quasi quindici anni, è diventato un artista affermato e affida all’allievo e conterraneo Antonio Gualdi il compito, arduo ma magistralmente assolto con le necessarie indicazioni dello stesso Minardi, di aggiornare la sua immagine di “saturnino intellettuale romantico” (Leone 2009), abbandonando idealmente la sofferta ma rassicurante retroguardia rappresentata dal suo giaciglio di fortuna ricavato nella stanzetta di Palazzo Corea per affrontare lo sguardo del mondo con una rinnovata consapevolezza.
Minardi non stringe più nel pugno il matitatoio, che avrebbe potuto scegliere per farsi rappresentare in maniera canonica, ma tra tutti gli oggetti affastellati nella soffitta porta con sé il teschio, che non giace più anonimamente alla sua sinistra ma guadagna il centro della composizione, accentuando la caratterizzazione in senso romantico e letterario del ritratto.
Il dipinto risente certamente della lezione dei nordici, che, mediata da Giani, influenzò Minardi durante la straordinaria stagione dell’Accademia de’ Pensieri, non solo per la presenza del teschio come nell’Autoritratto di John Flaxman (1779, Londra, University College), ma anche per la particolare posizione da pensatore rodiniano ante litteram, già sperimentata da Richard Cosway (Detroit, collezione privata) e, più in generale, per l’espressione intensa dallo sguardo vagamente allucinato che incontra Fuessli e James Barry.
La particolare iconografia del ritratto alimenta anche un’ipotesi interpretativa che intreccia la vicenda autobiografica del pittore e il suo culto quasi maniacale per la figura di Raffaello, complice il biennio (1819-1821) trascorso a Perugia come direttore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia e le visite frequentissime all’affresco dell’Urbinate nella Cappella di San Severo di cui stilò anche una particolareggiata relazione in vista di un possibile restauro. Nel 1821 Minardi fu richiamato a Roma per iniziare ufficialmente il suo lavoro all’interno dell’Accademia di San Luca, istituzione a cui dedicò oltre trent’anni della sua vita. Ma non fu semplice per il pittore ottenere la cattedra della scuola di disegno, lasciata vacante dopo la morte di Luigi Agricola, per la ferma opposizione alla sua nomina da parte dei professori anziani, su tutti Camuccini e Wicar. Servì l’intervento personale di Antonio Canova per sbloccare l’impasse e permettere a Minardi di fregiarsi del titolo che aveva inseguito con ostinazione. Da subito l’artista mostrò un’autentica devozione per il suo incarico che svolse sempre con inappuntabile professionalità, facendosi anche promotore di una riforma del programma di insegnamento. Nel 1827, anno in cui fu anche realizzato il ritratto, fu per lui un duro colpo sentirsi accusato dal solito Camuccini, che nutriva probabilmente un’avversione verso Minardi fin dai tempi in cui, giovanissimo, abbandonò la sua scuola per abbracciare le sperimentazioni gianesche, di essersi introdotto di notte nelle sale dell’Accademia per correggere gli elaborati dei suoi allievi al concorso del nudo. Minardi riuscì efficacemente a dimostrare la sua innocenza ma rimase certamente scottato perché era stata messa in dubbio la sua lealtà verso un’istituzione a cui aveva invece sempre dedicato tutto se stesso.
Questo spiacevole episodio potrebbe aver indotto nel pittore la necessità di rilanciare con forza il suo ruolo e la sua immagine in seno all’Accademia e, più in generale, di celebrare il suo sodalizio con l’istituzione, evocata nel ritratto dalla presenza del teschio, che, venerato e custodito gelosamente in una teca all’interno dell’Accademia, era creduto di Raffaello, al quale, sfruttando la duplice valenza simbolica, Minardi può tributare anche il suo personalissimo omaggio.
Per realizzare un’opera così densa di citazioni autobiografiche e rimandi simbolici, Minardi scelse Antonio Gualdi, che evidentemente reputava il più indicato tra gli allievi a recepire le sue indicazioni e a tradurle sulla tela secondo le più aggiornate suggestioni romantiche. Gualdi, giunto a Roma nel 1824 dopo un proficuo alunnato sotto Pietro Benvenuti e qualche buona prova offerta tra Parma e Firenze, non tradì le aspettative di Minardi, con cui lavorava a stretto contatto da quasi tre anni. In questo periodo di frequentazione “il tema socratico del maestro e dell’allievo, del dialogo intimo tra precettore e filosofo”, tanto caro al pittore faentino, declinato più volte in carriera come nell’Omero cieco in casa del pastore Glauco, poté compiutamente realizzarsi. E proprio “nel concetto della conoscenza, della trasmissione del sapere, nell’essenza della compartecipazione di stati profondi, nella condivisione intima di valori psicologici e sentimentali tra docente e discente” (Leone 2009) si riconoscono le fondamenta su cui Gualdi costruì il suo capolavoro.
MOSTRE
L’officina neoclassica. Dall’Accademia de’ Pensieri all’Accademia d’Italia. Faenza, Palazzo Milzetti, 15 marzo – 21 giugno 2009Literature
A. Ottani Cavina, in L’età neoclassica a Faenza 1780-1820, catalogo della mostra, Bologna 1979, pp. 113-114; S. Susinno, in Disegni di Tommaso Minardi (1787-1871), catalogo della mostra, Roma 1982, pp. XIX, 174-175; A. Ottani Cavina, Felice Giani 1758-1823 e la cultura di fine secolo, Milano 1999, I, pp. 58-59, 61; C. Mazzarelli, in Maestà di Roma. Universale ed Eterna Capitale delle Arti, catalogo della mostra, Milano 2003, I, p. 324; F. Leone, L’officina neoclassica. Dall’Accademia de’ Pensieri all’Accademia d’Italia, catalogo della mostra, Cinisello Balsamo 2009, pp. 45-46, 70, 77; F. Mazzocca, in Romanticismo, catalogo della mostra, Cinisello Balsamo 2018, pp. 244-245; E. Lissoni, ivi, p. 344.
2di 16
Iscriviti alla newsletter di Orsini arte e libri
* campi obbligatori
Tratteremo i dati personali che hai fornito in conformità con la nostra informativa sulla privacy (che trovi linkata nel footer). Puoi annullare l'iscrizione o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sul link presente nelle nostre email.