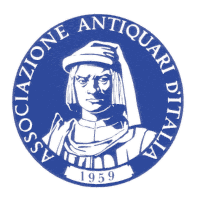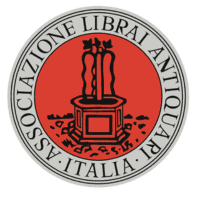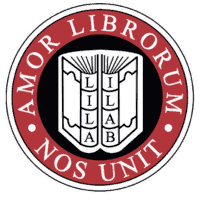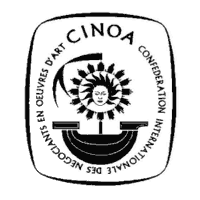-
Opere
Clemente Alberi
Ritratto di famiglia (con probabile autoritratto), 1833Olio su tela77x99 cmIscrizione sul retro della cornice: "Clemente Alberi"Il dipinto reca al verso una scritta a matita, che all’esame dei fatti si rivela attendibile, con il nome dell’autore, <Clemente Alberi>. I caratteri dell’opera corrispondono infatti allo stile, ben...Il dipinto reca al verso una scritta a matita, che all’esame dei fatti si rivela attendibile, con il nome dell’autore, <Clemente Alberi>. I caratteri dell’opera corrispondono infatti allo stile, ben noto, dell’Alberi, figlio d’arte e a lungo tra i protagonisti della cultura artistica accademica della città di Bologna: sono sufficienti raffronti con opere quali il Ritratto della contessa Giulia Tomani Amini, opera del 1831 di bella e sicura maniera, dell’assai più manierato Ritratto di Teresa Gavaruzzi Satti, del 1836, oppure delle due figure allegoriche dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, l’istituzione presso la quale l’artista condusse in massima parte il suo percorso ed esplicò il suo talento, per avere conferma della giustezza di quanto affermato dall’anonimo estensore della scritta antica. Non solo - ma anche - nei particolari che si prestano ad una analisi morelliana, quali il modo precipuo di definire gli occhi, le mani atteggiate secondo uno schema ripetuto perché funzionale - si vedano la mano sinistra della madre che regge il piccino al seno e la destra della Vanità del 1823, ad esempio -, la precisione minuziosa alla resa dei particolari, ma soprattutto in quell’allure vagamente sospesa, malinconica, che caratterizza i personaggi effigiati dall’artista soprattutto nel primo tempo della sua carriera.
Il giovane Alberi, istradato dal padre Raffaele, colonna portante dell’Accademia di Belle Arti bolognese nata nel 1804 dalle ceneri dell’Accademia Clementina di Pittura, Scultura e Architettura, gloriosa istituzione settecentesca soppressa dai francesi che anche quella vollero riformare, percorse tutti i gradini dell’incamminamento alla pittura secondo antica tradizione (da queste date sempre più restrittivi), affermandosi ai concorsi e misurandosi con le difficoltà della copia al punto da essere richiesto, in età matura, di repliche, tuttora in loco, per alcune delle più importanti pale d’altare bolognesi, già requisite da Napoleone e poi restituite dal Canova e collocate nella nuova Pinacoteca - per la chiesa di San Girolamo della Certosa la Comunione di san Girolamo di Agostino Carracci; la Santa Cecilia e santi di Raffaello per San Giovanni in Monte; la Pietà e i santi protettori di Bologna di Guido Reni per Santa Maria della Pietà -, con esiti assai lodati dai contemporanei. Percorse tutti i gradini della formazione; si misurò quindi con le difficoltà della pittura sacra e di storia, giusta la nuova moda, dipingendo più opere, purtroppo smarrite, delle quali esiste il ricordo grazie alle menzioni nelle fonti recuperate da Renzo Grandi, lo storico cui si devono le migliori ricerche sulla pittura del primo Ottocento. A noi è giunto, quale testimonianza di tale applicazione, il Martirio di santa Filomena del 1834, opera di sobrio quanto prevedibile pathos, frutto del lungo studio del pittore sui grandi precedenti della “Scuola di Belle Arti in Bologna” che "è incontrastabile essere stata una delle più distinte. Altra non ve n’ha che conti un maggior numero di celebri Professori. Le opere degli Artisti bolognesi sparse per tutta Europa formano il pregio de’ più cospicui Gabinetti”. Chi scrive è uno dei Professori dell’Accademia, Giacomo Rossi, che alla cerimonia inaugurale per l’apertura della medesima nel 1804 aveva investito la nuova generazione di una responsabilità enorme, usando le moderne/antiche parole della più consumata retorica: “In voi la Patria” ha “riposto le sue speranze, le Arti il loro sostegno, l’Italia la sua gloria”.
Ma il talento dell’Alberi era d’altro segno, altra la sua vocazione. Sebbene in non poche prove si era mostrato in accordo con le attese degli accademici e del padre scegliendo di narrare i fatti di Brunelleschi, Pitagora, Costantino Sforza e provandosi con il racconto della Scoperta del delitto di Caino ancora nel 1838, un anno prima dell’assegnazione della Cattedra di Pittura in Accademia, ambitissimo raggiungimento, Clemente aveva mostrato da tempo la sua propensione per la difficile arte del ritratto, che lo porterà a divenire quasi incontrastato protagonista in tal campo per l’élite non solo bolognese.
Per accrescere il suo background di conoscenze culturali, forse anche per sfuggire al clima della sua città troppo votato a rinverdire le glorie di un passato che non poteva tornare, scelse di recarsi a Firenze, dove all’esposizione nel 1827 presentò alcuni ritratti che riscossero il plauso degli intendenti per “bravura, verità e buon effetto”, caratteri questi che dagli anni venti sino alla sua piena maturità contraddistinsero la sua pittura segnandone il successo e procurandogli commesse dalla lontana Russia, dall’Inghilterra e dall’Irlanda, dal Portogallo, dalla Germania e ovviamente in Bologna, città della quale ha lasciato l’immagine, accanto quella degli esponenti dell’aristocrazia di censo, della buona borghesia laboriosa e progressista.
Gli esiti più felici della sua operosità sono dunque da ricercare nel campo a lui più consono, il cui catalogo, ancora in divenire, è stato accresciuto di numerosi esempi, ricercati da collezionisti e istituzioni; l’opera in questione, affascinante ritratto di famiglia en plein air, quasi il ricordo di una domenica in campagna di una famiglia il cui svago è allietato dalla musica di un pittore che ha deposto per un poco gli strumenti del mestiere che giacciono in primo piano accanto a lui, si aggiunge quale più che significativa operazione, per cronologia e per il plauso che riscosse al suo apparire.L’opera infatti è da riconoscere in quella che nel 1833 fu presentata all’annuale esposizione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. La breve descrizione fattane dal Muzzi, commentatore della mostra nel Repertorio Enciclopedico del 23 marzo di quell’anno, depone infatti in tal senso.
“Il Professore Clemente Alberi riminese, in una sola tela ha ritratto in grandezza naturale una intera famiglia. Chi non vede questa pittura, non può immaginarsi quant’armonia, esattezza, verità e buono stile vi regni. Alcuni accessori poi sono dipinti con tanta imitazione del vero, che si potranno uguagliare, forse non superare”.
Nelle parole del Muzzi l’eco dell’apprezzamento, sia pure temperato da consigli, riscosso dall’opera, che forse stupì i bolognesi per novità d’espressione rispetto a quanto antecedente al soggiorno in Toscana, il viaggio nelle Marche.
Fu particolarmente apprezzato il carattere di verità già sottolineato dalla Gazzetta di Firenze per le opere dell’esposizione del 1827 per il naturalismo nell’effigie dei personaggi ma soprattutto per i gustosissimi particolari, resi in termini quasi mimetici grazie ad una materia corposa e rinterzata. E certo, agli intendenti piacque il rimando alla cultura raffaellesca, che nel gruppo principale, la madre con suoi figli, è sottilmente evocata con un esito di grande efficacia, a dimostrazione della profonda cultura dell’Alberi, impegnato a dar prova di sé anche attraverso una prova di “buono stile”.Si tratta di un dipinto di certo fascino, nell’invenzione distesa e ben composta nei piani digradanti, dai due
gruppi in primo piano al lontano primaverile di una campagna luminosa e coltivata, sfondo ideale per una famiglia serena, il cui fulcro è, inevitabilmente, la figura materna, giovane donna elegante e in attesa dell’omaggio floreale che i due ragazzi sulla sinistra si apprestano a farle; accanto a lei la fanciulletta e il padre, il cui sembiante induce ad alcune, forse ardite, supposizioni. Dinanzi ad un’opera siffatta non è possibile evitare di interrogarsi sull’identità dei personaggi e proporre, con molta prudenza, di riconoscere nell’uomo con la tuba il conte Stefano Tomani Amini, che l’Alberi aveva ritratto nell’estate del 1831 secondo quanto affermato nella scritta al verso del dipinto, un personaggio che godette dell’amicizia dell’artista sino ai suoi tardi anni; la dama elegante ha alcune somiglianza con la contessa Giulia Tomani Amini - la forma del naso, l’ovale del volto, il taglio degli occhi - così da permettere uno slancio di fantasia. Ma più ancora è la quieta armonia del racconto, l’impronta di serenità e lieta amicizia che impronta l’immagine a far ipotizzare una familiarità tra i personaggi tale da poterne dedurre quasi l’identità, spingendosi ad identificare ne pittore musicista lo stesso Alberi, che sottolinea la sua presenza nello squillo rosso del mantello superbamente abbandonato sulle spalla, a creare contrasto con l’ocra vibrate del gilet.
7di 16
Iscriviti alla newsletter di Orsini arte e libri
* campi obbligatori
Tratteremo i dati personali che hai fornito in conformità con la nostra informativa sulla privacy (che trovi linkata nel footer). Puoi annullare l'iscrizione o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sul link presente nelle nostre email.