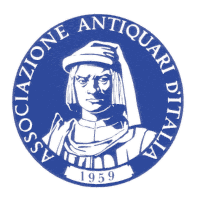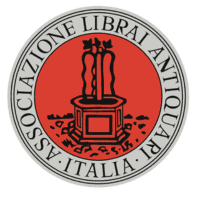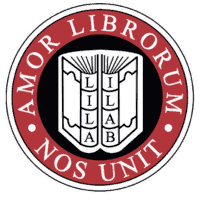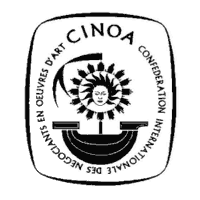-
Opere
Luigi Sabatelli
Olimpia abbandonata da Bireno, 1794 circapenna, inchiostro e acquerello su carta482 x 758 mmQuesto magnifico disegno, uno dei risultati più alti nella produzione grafica di Luigi Sabatelli, finora identificato ed esposto con il titolo errato di Armida abbandonata[1] , rappresenta in realtà un...Questo magnifico disegno, uno dei risultati più alti nella produzione grafica di Luigi Sabatelli, finora identificato ed esposto con il titolo errato di Armida abbandonata[1], rappresenta in realtà un altrettanto straziante e celebre abbandono, non dell’eroina tassesca, ma di Olimpia, tra le protagoniste dell‘Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Il foglio fa infatti parte della celebre serie dei quattordici disegni a penna di grande formato segnalati nell’Elenco delle opere del cav. Luigi Sabatelli, inserito nei Cenni biografici del pittore fiorentino raccolti e pubblicati nel 1900 dal figlio Gaetano, come facenti parte della collezione del marchese Gino Capponi (Firenze 1792 – 1876), prestigiosa figura di storico e patriota, mecenate di Sabatelli come il padre Pier Roberto (Firenze 1752 – 1839), figura fondamentale nella formazione e nell’incoraggiamento del giovane artista di cui era stato il primo a riconoscere il talento[2].
Peraltro Sabatelli era “nato dal popolo. Figlio di un cuoco dei Capponi di Firenze”, come ebbe a sottolineare Giuseppe Mazzini, nel suo celebre saggio del 1841 sulla Pittura Moderna in Italia, inserendolo dunque nella schiera degli artisti democratici, come Hayez, Bezzuoli, Migliara, da lui esaltati come i “nati dal popolo”[3].
Si trattava di soggetti di grande impegno, realizzati probabilmente tra il 1794 e il 1801, quindi tra la fine del decisivo soggiorno a Roma, il periodo di un anno e mezzo trascorso a Venezia ed il successivo ritorno a Firenze, dove si fermerà sino al 1808, quando raggiungerà definitivamente Milano, nominato, per l’autorevole intervento di Leopoldo Cicognara, professore di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, carica che ricoprì con grande autorevolezza sino alla morte nel 1850[4].
Seguendo la sua spiccata inclinazione verso le tematiche del sublime, maturata appunto nel vivace ambiente romano a contatto con una cultura figurativa internazionale e più specificatamente con la cerchia dei pittori inglesi facenti capo a Füssli, ma anche partecipando alla sperimentazione dell’Accademia de’ Pensieri riunita intorno a Felice Giani, Sabatelli esplorò nuovi e più stimolanti territori tematici, inoltrandosi nell’affascinante mondo della Divina Commedia dantesca, dei grandi poemi epici di Ariosto e Tasso. Probabilmente era in sintonia con gli interessi letterari del suo protettore, dato che si può supporre che la serie sia stata commissionata proprio da Pier Roberto Capponi, per poi passare in eredità al figlio Gino.
Significativo è dunque scorrere la lista di questi disegni, come riportata nei Cenni biografici: 1. L’orsa che difende i propri figli contro il cacciatore (Ariosto); Armida che trasporta Rinaldo sul carro di Amore (Tasso); 3. Adamo ed Eva in istato di innocenza; 4. Olimpia abbandonata da Bireno (Ariosto); 5. Il mago Ismeno che incanta la selva (Tasso); 6. Il sacco di Roma fatto dai Goti sotto Alarico; 7. Giovanni dalle Bande Nere al passaggio dell’Adda; 8. Ercole sul rogo; 9. Concilio infernale (Tasso); 10. Pietro Maranghi fiorentino dà fuoco a una nave pisana; 11. Orlando Pazzo (Ariosto); 12. Il Carroccio alla battaglia di Montaperti; 13. Farinata degli Uberti (Dante); 14. Farinata degli Uberti sotto le mura di Empoli.
Non sappiamo quando e come la raccolta sabatelliana di Gino Capponi venne dispersa. Ne ricomparve negli anni novanta del secolo scorso, messi sul mercato, una serie di cinque disegni, tra cui il nostro, e altri quattro fogli relativi ai numeri 2, 7, 11 e 13. Armida che trasporta Rinaldo sul carro d’Amore, passato da Colnaghi a Londra ed esposto nel 2000 alla grande mostra Art in Rome in the Eighteenth Century del Philadelphia Museum of Art e del Museum of Fine Arts di Houston, è stato poi acquisito dalla Yale University Art Gallery di New Haven[5].
L’Orlando Pazzo era entrato invece, acquistato nel 1999, nel fondo grafico del Philadelphia Museum of Art[6]. Mentre i tre rimanenti, Dante e Farinata, Giovanni dalle Bande Nere al passaggio dell’Adda e questo foglio sono rimasti insieme in una collezione privata, acquisiti, come gli altri, verso la metà degli anni novanta del secolo scorso, dalla raccolta di Dianora Guicciardini Canevaro, presumendo che vi fossero entrati, per lascito, dalla collezione Capponi[7].
Sabatelli ha subito il fascino dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, in un momento in cui, insieme alla Gerusalemme liberata del Tasso, questo poema aveva goduto di una rinnovata fortuna. Scelse la vicenda della lotta di Rodomonte e Orlando pazzo come soggetto del suo primo dipinto ad olio, eseguito a Roma all’inizio degli anni novanta, così come si ispirò a quello straordinario universo cavalleresco per molti disegni e incisioni. Pensiamo all’acquaforte con La morte di Zerbino, pubblicata a Roma nel 1796, al disegno con Orlando pazzo recupera il senno, assegnato al periodo veneziano dell’artista, tra il 1795-1797[8].
In questo caso possiamo pensare ad una cronologia verso il 1794, a conclusione del periodo di formazione a Roma. Del resto l’interesse per questa infelice eroina è da ricollegarsi alla recente fortuna che aveva goduto la sua vicenda, rappresentata da Giuseppe Cades nel famoso ciclo di affreschi dedicato al poema ariostesco realizzato in Palazzo Chigi ad Ariccia. Il riferimento è alla sequenza degli scomparti della prima sala risalenti al 1788, di cui proprio quello finale è relativo allo straziante episodio di Olimpia abbandonata dal suo amante Bireno[9].
La donna compare nei canti IX, X e XI dell’Orlando Furioso. Contessa di Olanda, è promessa sposa di Bireno. Viene corteggiata invano dal giovane e violento principe di Frisia Arbante. Dopo l’ennesimo rifiuto il padre del pretendente respinto Cimosco fa imprigionare Bireno e invade con il suo esercito le terre di Olimpia, per fare uccidere i parenti della nobildonna. Costretta con la forza a sposare Arbante, riesce a provocarne la morte il giorno stesso delle nozze e, dopo aver liberato Bireno con l’aiuto di Orlando, scampa anche alla vendetta del re Cimosco che verrà ucciso dal paladino di Francia. Ma avviene che Bireno, essendosi innamorato della figlia di Cimosco, abbandoni Olimpia su un’isola deserta, dove viene catturata dagli abitanti di Ebuda ed offerta da loro in pasto all’Orca. Salvata da Orlando, troverà il vero amore in Oberto, re di Ibernia.
Di queste complicate vicissitudini Cades e poi Sabatelli hanno rappresentato il commovente momento in cui Olimpia, dopo essersi svegliata scopre l’abbandono e si dispera sulla riva del mare. Sabatelli ha dunque espresso perfettamente con la potenza del suo disegno i seguenti versi:
[…] e corre al mar, graffiandosi le gote
presaga e certa ormai di sua fortuna.
Si straccia i crini, e il petto percuote,
e va guardando (che splendea la luna)
se vede cosa, fuor che ‘l lito puote…
Bireno chiama: e al nome di Bireno
rispondean gli Antri che pietà n’ avieno.
Il pittore fiorentino ha saputo rendere lo strazio di una vicenda che, tra Sei e Settecento, aveva ispirato grandi musicisti. Ricordiamo le fortunate opere liriche di Alessandro Scarlatti come l’Olimpia vendicata del 1865, l’Olimpia tradita del 1758 di Antonio Sacchini e nel 1768 l’Olimpia di Giovanni Paisiello.
Sabatelli ha fermato, decentrandola sulla destra, la figura dell’eroina sullo sfondo del mare e del cielo appena striato di nuvole e rischiarato dalla luce della luna. La posizione, inginocchiata sul ciglio della scogliera, e i gesti, con una mano protesa come alla ricerca disperata dell’amante perduto e l’altra con cui si strappa i capelli, sono di una straordinaria eloquenza. I tratti ad inchiostro, sottilissimi e sicuri, rivelano la maestria, ai limiti del virtuosismo, di questo grandissimo disegnatore.
Milano, 20 settembre 2024
Prof. Fernando Mazzocca
[1] A. Villari, scheda, in Il Neoclassicismo in Italia da Tiepolo a Canova, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2 marzo – 28 luglio 2002) a cura di F. Mazzocca, E. Colle, A. Morandotti, S. Susinno, Milano, Skira, 2002, p. 458. n. VI.45; L’officina neoclassica. Dall’Accademia de’ Pensieri all’Accademia d’ Italia, catalogo della mostra (Faenza, Palazzo Milzetti, 15 marzo -21 giugno 2009) a cura di F. Leone e F. Mazzocca, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, p. 128, n. V.4.
[2] Cenni biografici sul Cav. Prof. Luigi Sabatelli scritti da lui medesimo e raccolti dal figlio Gaetano, pittore, Milano, Stabilimento Tipografico Enrico Reggiani, 1900, p. 35, n. 4.
[3] Romantici e Macchiaioli. Giuseppe Mazzini e la grande pittura europea, catalogo della mostra (Genova, Palazzo Ducale, 21 ottobre 2005 – 12 febbraio 2006) a cura di F. Mazzocca, Milano, Skira, 2005, p. 34.
[4] E. Bairati, in Mostra dei Maestri di Brera (1776 – 1859), catalogo della mostra (Milano, Palazzo della Permanente, febbraio – aprile 1975) a cura di A. M. Brizio, M. Rosci e M. Dalai Emiliani, Milano, Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 1975 pp. 173-179.
[5] S. Susinno, scheda, in Art in Rome in the Eighteenth Century, catalogo della mostra (Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 16 marzo – 18 maggio 2000; Houston, The Museum of Fine Arts, 25 giugno – 17 settembre 2000) a cura di E. P. Bowron e J. Rishel, Philadelphia, Philadlelphia Museum of Art, 2000, pp. 553-554, n. 400; P. Franklin. Due nuovi disegni di Sabatelli padre e figlio, in “Master Drawings”, autunno 2000, p. 347.
[6] A. Percy e M. Cazort, Italian Master Drawings at Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 2004, s.p. n 62 (ed. italiana I grandi disegni italiani del Philadelphia Museum of Art, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale 2004, n. 62).
[7] Tutti e tre i disegni sono stati esposti nella mostra di Faenza L’ Officina neoclassica cit., pp. 127-129, nn. V.3 – V.5.
[8] Su questi due bellissimi fogli conservati al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi si rimanda a Luigi Sabatelli (1772 – 1850). Disegni e Incisioni. Saggi introduttivi di Carlo del Bravo e Beatrice Paolozzi Strozzi. Catalogo a cura di Beatrice Paolozzi Strozzi, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1978, pp. 39-40, nn. 24-25.
[9] M. T. Caracciolo, Giuseppe Cades 1750 – 199 et la Rome de son temps, Paris, Arthena, 1992, pp. 129-130.
Provenance
Firenze, collezione marchese Gino Capponi; Firenze, collezione Dianora Guicciardini Canevaro; Firenze, collezione privataMOSTRE
Il Neoclassicismo in Italia, da Tiepolo a Canova, Milano, Palazzo Reale, 2 marzo – 28 luglio 2002; L’officina neoclassica. Dall’Accademia de’ Pensieri all’Accademia d’Italia, Faenza, Palazzo Milzetti, 15 marzo – 21 giugno 2009.
1di 23
Iscriviti alla newsletter di Orsini arte e libri
* campi obbligatori
Tratteremo i dati personali che hai fornito in conformità con la nostra informativa sulla privacy (che trovi linkata nel footer). Puoi annullare l'iscrizione o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sul link presente nelle nostre email.