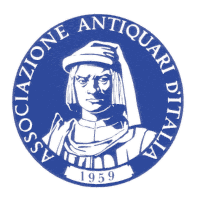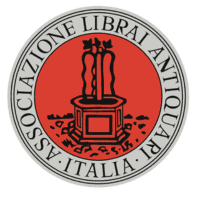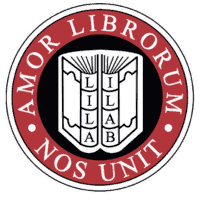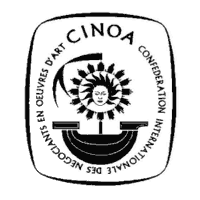-
Opere
Luigi Sabatelli
Dante e Farinata, 1801 circaPenna e inchiostro bruno e acquerello su carta400 x 720 mm disegno, 575 x 853 mm foglio
Questo importante foglio, uno dei capisaldi dell’iconografia dantesca, che ha goduto di una recente fortuna espositiva[1] , fa parte della magnifica serie dei quattordici disegni a penna di grande formato...Questo importante foglio, uno dei capisaldi dell’iconografia dantesca, che ha goduto di una recente fortuna espositiva[1], fa parte della magnifica serie dei quattordici disegni a penna di grande formato segnalati nell’ Elenco delle opere del cav. Prof. Luigi Sabatelli, inserito nei Cenni biografici del pittore fiorentino raccolti e pubblicati nel 1900 dal figlio Gaetano, come facenti parte della collezione del marchese Gino Capponi (Firenze 1792 -1876), prestigiosa figura di storico e patriota, mecenate del Sabatelli come il padre Pier Roberto (Firenze 1752 – 1839), figura fondamentale nella formazione e nell’incoraggiamento del giovane artista di cui era stato il primo a riconoscere il talento[2].
Si trattava di soggetti di grande impegno, realizzati probabilmente tra il 1794 e il 1801, quindi tra la fine del decisivo soggiorno a Roma, il periodo di un anno e mezzo trascorso a Venezia ed il successivo ritorno a Firenze, dove di fermerà e sarà attivo sino al 1808, quando raggiungerà definitivamente Milano, nominato, per l’autorevole intervento di Leopoldo Cicognara, professore di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, carica che ricoprì con grande autorevolezza sino alla morte nel 1850[3].
Seguendo la sua inclinazione verso le tematiche del sublime, maturata appunto nell’ambiente romano a contatto con una cultura figurativa internazionale e più specificatamente la cerchia dei pittori inglesi facenti capo a Füssli, ma anche partecipando alla sperimentazione dell’Accademia de’ Pensieri riunita intorno a Felice Giani, Sabatelli esplorò nuovi territori tematici, inoltrandosi nell’affascinante mondo della Divina Commedia dantesca, dei grandi poemi epici di Ariosto e Tasso. Probabilmente era in sintonia con il suo protettore, dato che si può supporre che la serie sia stata commissionata proprio da Pier Roberto Capponi, e poi sia passata in eredità al figlio.
Significativo è dunque scorrere la lista di questi disegni, come riportata nei Cenni biografici: 1. L’orsa che difende i propri figli contro il cacciatore (Ariosto); 2. Armida che trasporta Rinaldo sul carro di Amore (Tasso); 3. Adamo ed Eva in istato d’innocenza; 4. Olimpia abbandonata da Bireno (Ariosto); 5. Il mago Ismeno che incanta la selva (Tasso); 6. Il sacco di Roma fatto dai Goti sotto Alarico; 7. Giovanni delle Bande Nere al passaggio dell’Adda; 8. Ercole sul rogo; 9. Il Concilio infernale (Tasso); 10. Pietro Maringhi fiorentino dà fuoco a una nave pisana; 11. Orlando Pazzo (Ariosto); 12. Il Carroccio alla battaglia di Montaperti; 13. Farinata degli Uberti (Dante); Farinata degli Uberti sotto le mura di Empoli.
Non sappiamo quando e come la raccolta sabatelliana del Capponi venne dispersa. Ne ricomparve negli anni novanta del secolo scorso, messi sul mercato, una serie di cinque disegni, tra cui il nostro, e altri quattro relativi ai numeri 2, 4, 7 e 11 della lista. Armida che trasporta Rinaldo sul carro d’Amore, passato da Colnaghi a Londra ed esposto nel 2000 alla grande mostra Art in Rome in the Eighteenth del Philadelphia Museum of Art e del Museum of Fine Arts di Houston, è stato poi acquisito dalla Yale University Art Gallery di New Haven[4]. L’Orlando pazzo è entrato invece, acquistato nel 1999, nel fondo grafico del Philadelphia Museum of Art[5]. Mentre i rimanenti tre, Olimpia abbandonata da Bireno, Giovanni delle Bande Nere al passaggio sull’Adda e il nostro sono rimasti insieme in una collezione privata, acquisiti come gli altri, verso la meta degli anni novanta del secolo scorso, dalla raccolta di Dianora Guicciardini Canevaro, presumendo che vi fossero entrati, per lascito, dalla collezione Capponi[6].
Nei quattordici disegni Capponi non mancano anche incursioni nella storia in particolare fiorentina, tra le imprese del leggendario Giovanni delle Bande Nere e il terribile massacro della battaglia di Montaperti evocata da Dante (“Lo strazio e ‘lgrande / Scempio / Che fece l’Arbia colorata in rosso”) proprio nel canto X dell’Inferno dove avviene l’incontro con Farinata reso con tanta potenza in questo disegno relativo ai mirabili versi, tra i più citati del poema:
Vedi là Farinata che s’è dritto:
Da la cintola in su tutto il vedrai.
Io avea già il mio viso nel suo fitto;
Ed el s’ergea col petto e con la fronte
Com’ avesse l’ inferno in gran dispitto”.
La straordinaria qualità di questo foglio gli meritò l’esposizione alla grande mostra del Centenario Dantesco, allestita a Firenze nel 1865. Compare infatti nel catalogo come inviato dal marchese Gino Capponi, con l’aggiunta dei versi 91-93 del canto X, in parte scritti sulla montatura originale del nostro disegno: “E fui io sol colà dove sofferto / Fu per ciascun di torre via Fiorenza, / Colui che la difese a viso aperto.”. Infatti la scena rappresentata da Sabatelli dà il massimo rilievo proprio al gesto eroico e all’enfasi che caratterizzano l’orgogliosa rivendicazione patriottica del grande condottiero ghibellino.
Per quanto riguarda la cronologia, rispetto ad una primitiva collocazione intorno al 1794, Monica Cardarelli[7] propone giustamente di avanzarla al 1801, per la vicinanza alla celebre acquaforte della Peste di Firenze, di cui si ritrova il “raffinato e minutissimo tratteggio”[8].
Vanno poi segnalate la grande forza compositiva e la straordinaria resa dei dettagli, dai panneggi di Dante alle rocce, al fumo, alla risentita anatomia michelangiolesca del condottiero, tutti elementi che concorrono alla resa dell’atmosfera infernale. Protagonista assoluto è Farinata che emerge con grande potenza, “come un gigante”, dal suo sepolcro, ritratto proprio dalla cintola in su come nei versi danteschi.
Altrettanto efficace è la gestualità, con il braccio destro teso ed il dito puntato e la mano sinistra sul petto, posa che richiama quella di un oratore antico. Dante è collocato in primo piano, di profilo, ma quasi di spalle, avvolto nella sua tunica dalle ampie pieghe. Appare intento ad ascoltare, in una posizione ravvicinata, le parole di Farinata; mentre la figura di Virgilio con le braccia conserte si affaccia, più defilata, nel fondo a destra. Dal suolo emergono dei sepolcri infuocati dove, in parte, si intravvedono i volti “sgomenti e rassegnati” degli eretici dannati in quella bolgia.
Vanno messi in relazione al nostro disegno altri fogli di minori dimensioni ed impegno, in particolare quello, assegnato al 1795, conservato al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi. Appare diverso nella composizione con la figura di Farinata collocata a destra e quelle di Dante e Virgilio a sinistra, quindi specularmente invertito rispetto a nostro. Mentre la stesura grafica appare più sommaria rispetto alla ricchezza del nostro[9].
Ancora diversa è l’acquaforte disegnata da Sabatelli e incisa da Damiano Pernati, pubblicata a Roma nel 1797 e conservata alle Civiche Raccolte delle Stampe “Achille Bertarelli” di Milano, dove Dante e Virglio incontrano Farinata degli Uberti e Cavalcante. Insieme alla figura di Farinata emerge dal sepolcro infernale, anche se col solo volto, quella di Calvalcante, per illustrare i versi: “Allor surse alla vista scoperchiata / Un’ ombra, lungo questa, infino al mento: / Credo che s’era in ginocchio levata”.[10]
Al Civico Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco di Milano esiste infine un piccolo ma potente schizzo a penna, in cui Sabatelli studia in due riprese, raffigurandole nude e vestite, la figura di Virgilio che mostra a Dante Farinata e Cavalcante [11].
Milano, 20 settembre 2024
Prof. Fernando Mazzocca
[1] L’ officina neoclassica. Dall’ Accademia de’ Pensieri all’ Accademia d’Italia, catalogo della mostra (Faenza, Palazzo Milzeti, 15 marzo – 21 giugno 2009) a cura di F. Leone e F. Mazzocca, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2009, p. 127, n. V. 3; M. Cardarelli, scheda, in Dante. La visione dell’arte, catalogo della mostra (Forlì, Musei San Domenico, 30 aprile – 11 luglio 2021) a cura di G. Brunelli, F. Mazzocca, A. Paolucci, E. D. Schmidt, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2021, p. 485, n. 214,
[2] Cenni biografici sul Cav. Prof. Luigi Sabatelli scritti da lui medesimo e raccolti dal figlio Gaetano, pittore, Milano, Stabilimento Tipografico Enrico Reggiani, 1900, pp. 34-35.
[3] E. Bairati, in Mostra dei Maestri di Brera (1776 – 1859), catalogo della mostra (Milano, Palazzo della Permanente, febbraio – aprile 1975), a cura di A.M. Brizio, M. Rosci e M. Dalai Emiliani, Milano, Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 1975, pp. 173-179.
[4] S. Susinno, scheda, in Art in Rome in the Eighteenth Century, catalogo della mostra (Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 16 marzo – 18 maggio 2000; Houston, The Museum of Fine Arts, 25 giugno – 17 settembre 200), a cura di E. P. Bowron e J. Rishel, Philadedlphia, Philadelphia Museum of Art, pp. 553-554, n. 400; P. Franklin, Due nuovi disegni di Sabatelli padre e figlio, in “Master Drawings”, autunno 2009, p. 347.
[5] A. Percy e M. Cazort, Italian Master Drawings at Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 2004, s.p., n. 62 (ed. italiana I grandi disegni italiani del Philadelphia Museum of Art, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2004, n. 62).
[6] Questi tre sono stati esposti e pubblicati nella mostra di Faenza L’Officina neoclassica cit., pp. 127-129, nn. V.3 – V.5.
[7] Alla studiosa di deve il contributo più aggiornato sull’ artista fiorentino: M. Cardarelli, Luigi Sabatelli. La Sala dell’ Iliade di Palazzo Pitti, Firenze, Edizioni Polistampa, 2021.
[8] M. Cardarelli, scheda, in Dante la visione dell’ arte cit., p. 485.
[9] Luigi Sabatelli (1772-1850). Disegni e incisioni. Saggi introduttivi di Carlo del Bravo e Beatrice Paolozzi Strozzi. Catalogo a cura di Beatrice Paolozzi Strozzi, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1978, p. 32, n. 16; M. Cardarelli, scheda, in Dante. La visione dell’arte cit., p. 449, n. 105.
[10] G. K. Nagler, Neues allgemeines Künstler Lexikon, I-XXV, Leipziz 1835-1852, p. 532, n. 33.
[11] E. Bairati, scheda, in Mostra dei Maestri di Brera cit., p. 175, n. 162.
Provenance
Provenienza: Firenze, collezione marchese Gino Capponi; Firenze, collezione Dianora Guicciardini Canevaro; Firenze, collezione privata.
MOSTRE
Esposizioni: Mostra del Centenario Dantesco, Firenze, 1865; L’officina neoclassica. Dall’Accademia de’ Pensieri all’Accademia d’Italia, Faenza, Palazzo Milzetti, 15 marzo – 21 giugno 2009; Dante. La visione dell’arte, Forlì, Musei di San Domenico, 30 aprile – 11 luglio 2021.
2di 23
Iscriviti alla newsletter di Orsini arte e libri
* campi obbligatori
Tratteremo i dati personali che hai fornito in conformità con la nostra informativa sulla privacy (che trovi linkata nel footer). Puoi annullare l'iscrizione o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sul link presente nelle nostre email.