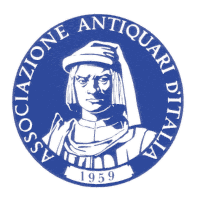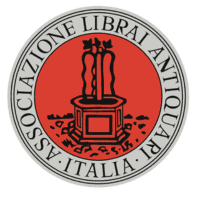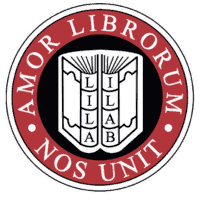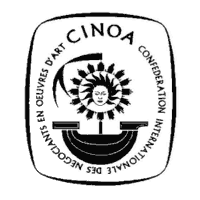-
Opere
Giacomo Quarenghi
Capriccio architettonico con antichi monumenti (Scenografia), 1770 – 1775 circaChina e acquerello a colori su carta600 x 750 mmFirmato sul basamento della sfinge a destra: “Jacopo Quarenghi”
Scritta a inchiostro, in basso a sinistra: “Proprietà Carrara”
Questo grande foglio riveste un carattere di unicità, per la sua alta qualità esecutiva e la singolarità iconografica, nell’ ambito della vasta produzione grafica del grande architetto Giacomo Quarenghi. Di...Questo grande foglio riveste un carattere di unicità, per la sua alta qualità esecutiva e la singolarità iconografica, nell’ ambito della vasta produzione grafica del grande architetto Giacomo Quarenghi. Di provenienza illustre, come attesta la scritta in basso a sinistra che rimanda ai Carrara celebre famiglia di collezionisti bergamaschi, era stato pubblicato nel 1984, con riferimento alla raccolta Bartsch[1] nel fondamentale catalogo dedicato a Quarenghi nella serie dei “Monumenta Bergomensia”[2].
Schedato genericamente con il titolo di Scenografia, si rivela invece come una straordinaria invenzione grafica, un vero e proprio capriccio architettonico caratterizzato da una complessa e originale iconografia che rimanda agli anni, tra il 1763 e il 1775, della formazione a Roma dove il geniale artista bergamasco è venuto a contatto con l’ambiente cosmopolita ed effervescente di quella che era allora considerata la capitale universale delle arti[3].
Il foglio, sicuramente collocabile in quel periodo, presenta delle caratteristiche, iconografiche e formali, che rimandano alla eccezionale cultura antiquaria e alla sperimentazione figurativa proprie della Roma di quegli anni.
Questo superbo disegno fonde, con grande efficacia e notevole suggestione, elementi naturali e invenzioni architettoniche ispirate all’ antichità, sia greca che egizia. Sorprende l’estro con cui il giovane architetto ha saputo incorniciare l’immagine, inquadrandola in primo piano ai due lati e alla base in una cortina di vegetazione, con la rappresentazione di vecchi alberi contorti e cardi fioriti. Questi elementi che rimandano ad una sensibilità paesistica vicina a Jakob Philipp Hackert, allora operante a Roma dove Quarenghi può aver visto sicuramente le sue opere.
Peraltro questo suggestivo abbinamento è presente anche nelle incisioni di Giovanni Battista Piranesi, da lui frequentato, ammirato e studiato[4]. La stessa caratteristica del capriccio architettonico abbinato a degli alberi che contornano l’immagine la ritroviamo in un foglio, anch’ esso riferibile al periodo romano, conservato all’ Accademia Carrara di Bergamo con il titolo Fantasia nello spirito di Piranesi[5]. Si tratta di un acquerello peraltro molto simile al nostro come stile, anche se non presenta la stessa qualità ed appare assai più semplice nell’ invenzione iconografica.
Lo stesso gusto lo ritroviamo nelle fantasie architettoniche sull’antico del francese Charles Louis Clérisseau, a Roma dal 1749, ed in seguito anche lui attratto dalla corte russa di Caterina II. Significativo è il confronto con una splendida gouache del Soane’s Museum di Londra rappresentante una Camera sepolcrale, dove compare lo scenografico motivo dell’arco oltre al quale si scorgono degli edifici[6]. Questo dettaglio è frequente anche nelle vedute immaginarie di Hubert Robert che, negli anni italiani dal 1756 al 1764, si era confrontato in tale genere con Giovanni Paolo Panini e Piranesi[7].
Quarenghi, in questo foglio eccezionale soprattutto per l’estro dell’invenzione, si distacca da questi esempi nella varietà degli elementi iconografici che ha saputo inserire in un’immagine che proprio per questa complessità, insolita nei consueti capricci architettonici, potrebbe far pensare proprio ad una scenografia dove gli elementi di fantasia assumono una ricchezza e una prevalenza maggiori.
Il percorso inventivo, che passa da un piano all’altro, è assolutamente avvincente. La fantasia architettonica che si intravvede oltre l’arco delimitato in alto da volute e bucrani con la volta a cassettoni ornati da rosoni, presenta elementi diversi in un accrochage davvero estroso proprio per la varietà dei riferimenti ad epoche e stili diversi.
Sullo sfondo in alto di intravvede la sagoma della Torre di Babele, con davanti le mura e la torre merlate di un castello medievale. Dopo una quinta di alberi si erge un obelisco egizio davanti ad un portico a colonne dorico. Sempre all’ordine dorico, allora oggetto di interesse da parte soprattutto degli architetti dopo la riscoperta dei templi di Paestum[8], afferisce anche il frontone che introduce ad un monumentale mausoleo, o sepolcro, in forma di piramide con un lungo fregio e una targa incisa. Nella vertiginosa scalinata d’accesso si intravvedono delle piccole sagome animate; mentre una schiera di guerrieri armati, tra cui i due più evidenti sembrano indossare un antico costume egizio, avanzano verso il primo piano. Elemento questo che sembra confermare l’ipotesi che si tratti di una scenografia. L’immagine è arricchita da altri due significativi dettagli, come la sfinge di profilo, nel cui basamento Quarenghi ha inserito la sua forma, e il gufo, animale notturno, che conferisce un tocco di brivido “gotico” alla scena.
Prof. Fernando Mazzocca
[1] Potrebbe riferirsi che fosse passato dalla raccolta Carrara a quella di Johan Adam Bernhard von Bartsch (Vienna 1757 - Hietzing 1821), scrittore e incisore austriaco, noto soprattutto per il suo monumentale corpus dedicato all’incisione, intitolato Le Peintre-graveur, compilato a Vienna dal 1802 alla sua morte nel 1821, e poi pubblicato in 14 volumi a Parigi, in cui ha descritto le opere degli incisori olandesi, fiamminghi e tedeschi sino al 1820, nonché di incisori italiani dal XV al XVII secolo.
[2] Giacomo Quarenghi, a cura di S. Angelini, testo di V. Piljavskij, catalogo di V. Zanella. Monumenta Bergomensia LXVII, Bergamo, Credito Bergamasco, e Cinisello Balsamo (Milano), Amilcare Pizzi, 1984, pp. 408-409, n. 1012.
[3] Su questo fondamentale periodo si rimanda agli studi più aggiornati raccolti per il convegno Giacomo Quarenghi e la cultura architettonica britannica. Da Roma a San Pietroburgo. Atti del convegno internazionale (Roma, Palazzo Carpegna, 25-26 maggio 2017) a cura di P. Angelini, I Giustina, T. Manfredi e F. Moschini, Roma, Accademia Nazionale di San Luca, 2021.
[4] L. Ficacci, Giovanni Battista Piranesi. Catalogo completo delle acqueforti, Köln. London, Madrid, New Yor, Paris, Tokio, Taschen, 2001, pp. 411, 428, 467..
[5] Giacomo Quarenghi cit., p. 18.
[6] Charles-Louis Clérisseau (1721 – 1820). Dessins du musée de l’Ermitage Saint-Pétersbourg, catalogo della mostra (Parigi, Musée du Louvre, 21 settembre – 18 dicembre 1995) a cura di V. Chevtchenko, S.Cotté e M. Pinault Sørensen, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1995, p. 31.
[7] Hubert Robert 1733 – 1808. Un peintre visonnaire, catalogo della mostra (Parigi, Musée du Louvre, 8 marzo – 30 maggio 2016 e Washington, National Gallery of Art, 26 giugno 2 ottobre 2016) a cura di G. Faroult, Paris, Somogy. Editions du Louvre, 2016.
[8] La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico, 1750-1830, a cura di J. Raspi Serra e G. Simoncini, 2 voll., Firenze, Centro Di, 1986.
Provenance
Bergamo, Collezione Carrara (come indicato sul passepartout originale); Vienna, John Adam Bernard von Bartsch; Milano, collezione privata.
9di 23
Iscriviti alla newsletter di Orsini arte e libri
* campi obbligatori
Tratteremo i dati personali che hai fornito in conformità con la nostra informativa sulla privacy (che trovi linkata nel footer). Puoi annullare l'iscrizione o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sul link presente nelle nostre email.