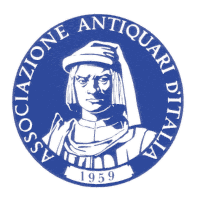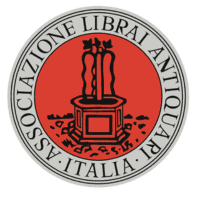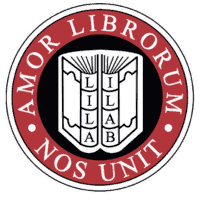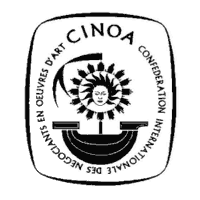-
Opere
Open a larger version of the following image in a popup: O. Panini, Candeliere, Parma, chiesa di S. M. della Steccata
Open a larger version of the following image in a popup:
O. Panini, Candeliere, Parma, chiesa di S. M. della Steccata
Open a larger version of the following image in a popup: E. A. Petitot, Incisione tratta dal volume Mascarade à la Grecque
Open a larger version of the following image in a popup:
E. A. Petitot, Incisione tratta dal volume Mascarade à la Grecque
Open a larger version of the following image in a popup: E. A. Petitot, Progetti per candelieri, collezione privata
E. A. Petitot, Progetti per candelieri, collezione privata
Odoardo Panini
Coppia di candelieri, ultimo decennio del XVIII secoloLegno intagliato e doratoh 113 cm.Further images
I due candelieri presentano, nella loro articolata forma architettonica, inequivocabili analogie con una serie di esemplari affini (fig. 1) realizzati dall’intagliatore parmense Odoardo Panini per l’altare della chiesa parmense di...I due candelieri presentano, nella loro articolata forma architettonica, inequivocabili analogie con una serie di esemplari affini (fig. 1) realizzati dall’intagliatore parmense Odoardo Panini per l’altare della chiesa parmense di Santa Maria della Steccata[1]. Il 24 luglio del 1797 infatti fu stipulato un contratto tra i responsabili dell’Ordine Costantiniano – che dal 1718 ha la sua sede presso la basilica – e il Panini per l’esecuzione di ben dodici candelieri, una croce e sei vasi per l’altare maggiore dopo che gli originari arredi d’argento erano stati tolti per pagare il tributo richiesto da Napoleone. Il modello di questo nuovo insieme fu fornito da Panini stesso insieme all’intagliatore Antonio Salvini che però si ritirò quasi subito dall’impresa poi portata avanti dal solo Panini, che si impegnò a fornire altri quattordici candelieri dei quali sei senza ricevere alcun compenso.
L’originale disegno strutturale dei nostri candelieri, che dalla base si sviluppa verso l’alto grazie alla studiata disposizione delle volute di foglie d’acanto che fanno da raccordo agli ornati architettonici in un crescendo armonico terminante in alto nella coppa porta cero, può essere inteso come una raffinata variante degli esemplari della chiesa della Steccata la cui forma più rigida venne qui ingentilita secondo un progetto decorativo ancora il linea con il gusto neoclassico di matrice francese. Uno stile ben conosciuto a Parma grazie all’attività di Ennemond Alexandre Petitot, giovane e brillante architetto allievo di Soufflot a Parigi, chiamato nella capitale del ducato dal ministro Guillaume du Tillot con l’arduo compito di elaborare quel particolare stile neoclassico parmense che, fondato sui rigorosi precetti dettati dagli illuministi francesi, si era sviluppato su quel classicismo “composito e bizzarro” di Piranesi.
Si delineavano così durante gli anni Cinquanta del secolo nei cantieri di corte e nelle aule dell’Accademia di quella piccola Atene che fu Parma, i primi fondamenti della nuova maniera d’ornare - divulgata anche attraverso repertori di incisioni quali ad esempio Suite de Vases o Mascarade à la Grecque (fig. 2) incise da Benigno Bossi nel 1764 e nel 1771 – di lì a poco accolta da sovrani illuminati quali Pietro Leopoldo di Toscana e il fratello Ferdinando I d’Asburgo Arciduca di Milano.
Le forme e i motivi decorativi neoclassici introdotti da Petitot a Parma, evidenti negli arredi superstiti[2], furono ben presto messi in pratica dagli intagliatori attivi nella città, tra i quali i più importanti furono sicuramente Ignazio Marchetti e Odoardo Panini, che, discostandosi dalle ormai abusate forme rocailles, tradussero in pratica le precoci idee neoclassiche di Petitot. Tra i primi lavori eseguiti dai citati artigiani su disegni dell’architetto di corte si annoverano infatti gli scaffali della Biblioteca Palatina realizzati nel 1768 secondo strutture severe appena ravvivate dall’inserimento delle ghirlande di foglie d’alloro e dei vasi, la cui originale forma richiama quella dei prototipi incisi nel 1764. Dopo questa impegnativa impresa il solo Panini realizzò nel 1781 l’altare maggiore della chiesa di San Pietro e, a partire dall’anno successivo, fu operoso fino al 1791 in Palazzo Sanvitale dove eseguì diversi arredi, oggi in gran parte dispersi, continuando contemporaneamente a lavorare per la corte borbonica fino al 1811 quando, in un documento relativo al censimento effettuato in quell’anno, l’intagliatore, ormai anziano e paralizzato, si trovava ospitato dal figlio Angelo che nel frattempo ne aveva proseguito l’attività[3].
La coppia di candelieri qui analizzati, verosimilmente dipendenti da progetti elaborati dallo stesso Petitot (fig. 3), costituisce dunque una ulteriore testimonianza dell’evoluzione dello stile di corte parmense anticipatore di sempre nuove forme di stampo neoclassico e in continua evoluzione per tutta la seconda metà del Settecento, fornendo idee e modelli in ogni campo dell’arredo in netto anticipo rispetto a quanto stava avvenendo negli altri Stati italiani.
Enrico Colle
[1] I candelieri, pubblicati da L. Bandera, Il mobile emiliano, Milano 1972, p. 181, fig. 248, sono stati ricondotti al Panini da G. Bertini, Odoardo Panni scultore, in ‘Antologia di Belle Arti’, nn. 9 – 12, 1979, p. 164, fig. 7 dove, alla nota 17, si rendono noti anche i relativi documenti conservati presso l’archivio dell’Ordine Costantiniano.
[2] Si veda a questo proposito il capitolo dedicato al Ducato di Parma in E. Colle, Il mobile neoclassico in Italia. Arredi e decorazioni d’interni dal 1775 al 1800, Milano 2005, pp. 227 – 259.
[3] Per le notizie circa l’intagliatore si rimanda alla scheda biografica redatta da G. Zavatta in E. Colle, Il mobile neoclassico in Italia. Arredi e decorazioni d’interni dal 1775 al 1800, Milano 2005, pp. 227 – 259.
1di 5
Iscriviti alla newsletter di Orsini arte e libri
* campi obbligatori
Tratteremo i dati personali che hai fornito in conformità con la nostra informativa sulla privacy (che trovi linkata nel footer). Puoi annullare l'iscrizione o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sul link presente nelle nostre email.