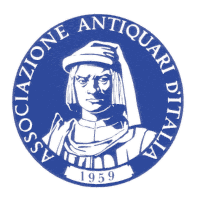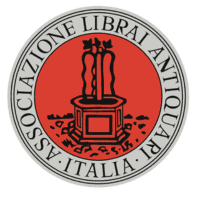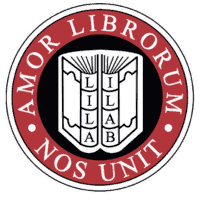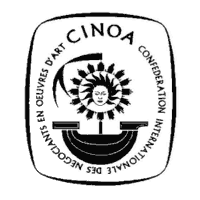-
Opere
Giuseppe Colzi (?)
Scrittoio, Terzo decennio del XIX secoloLegno impiallacciato di mogano, radica di olmo e legno tinto a imitazione dell’ebano, applicazioni di metallo dorato, piano di marmo, 106 x 92,5 x 49 cm.Protagonista di spicco della pittura romantica toscana, soprattutto di quella ispirata al romanticismo storico, Giuseppe Bezzuoli durante tutta la prima metà dell’Ottocento ebbe modo di frequentare gli ambienti della corte...Protagonista di spicco della pittura romantica toscana, soprattutto di quella ispirata al romanticismo storico, Giuseppe Bezzuoli durante tutta la prima metà dell’Ottocento ebbe modo di frequentare gli ambienti della corte lorenese ricevendo molte commissioni da parte dei granduchi e dell’aristocrazia fiorentina. L’artista maturò così, a stretto contatto con gli architetti e i decoratori attivi nelle residenze granducali, un suo proprio gusto per l’arredamento degli interni in linea con quella ricercata semplicità tipica del gusto Biedermeier assai apprezzato soprattutto dal granduca Leopoldo II che resse le sorti del Granducato dal 1824 fino all’Unità d’Italia.
Dopo la scomparsa di Ferdinando III la vita di corte a Firenze, con i suoi ritmi scanditi dalle cerimonie e dalle feste, fu improntata ad una maggiore semplicità rispetto agli anni napoleonici. Leopoldo II amava infatti trascorrere gran parte della propria giornata insieme alla famiglia in un’intimità quasi borghese, fatta di frequenti gite nelle ville da dove partiva per lunghe passeggiate durante le quali sovente si fermava nelle case dei contadini, di cui ammirava lo stile di vita patriarcale che, secondo le sue idee, si sarebbe dovuto estendere anche alla conduzione del governo granducale: “La Toscana , una piccola famiglia attende a goder della felicità domestica – scriveva nei suoi diari -, attende a educar i figli, ad amministrare il patrimonio, a dissodar e coltivar terreni: felice lei se potrà presentare agli occhi altrui questa immagine di felice quiete e di industria operosa”.
La Firenze della Restaurazione, dove nel frattempo Bezzuoli era divenuto un artista acclamato, era una città caratterizzata dal quieto vivere dei suoi abitanti rispecchiato nei sobri interni in cui gli elaborati arredi settecenteschi potevano ben essere accoppiati con le più confortevoli poltrone dalle soffici imbottiture, mentre le ridondanti dorature, caratteristiche dell’ancien régime, venivano abilmente attenuate grazie al felice contrasto con i toni bruni dalla mobilia impiallacciata di mogano e ai tendaggi drappeggiati secondo sempre più originali disegni.
Era quello che stavano facendo i restaurati granduchi lorenesi, i quali rivolsero la loro attenzione, nel campo della decorazione e dell’ammobiliamento delle loro residenze, soprattutto al completamento dei lavori degli ex appartamenti imperiali, intrapresi anni prima da Elisa Baciocchi, ordinando agli architetti di corte Giuseppe Cacialli e Pasquale Poccianti di elaborare, oltre ai progetti per le decorazioni di questi ambienti, anche i disegni della mobilia che li doveva arredare, la cui esecuzione spettò in massima parte agli ebanisti Giuseppe Benvenuti, Giuseppe Colzi, Giovanni e Luigi Socci, Jacopo Ciacchi e agli intagliatori Ranieri Bardi, Lorenzo Ristori e Paolo Sani.
Osservando i mobili eseguiti dagli ebanisti di corte in questo giro d’anni si avverte chiaramente una evoluzione dello stile toscano intesa a ricercare nuove forme e modelli in grado di competere con quanto si andava facendo negli altri Stati italiani. Tale ricerca si esplicò nell’adozione di strutture architettoniche derivate da un tardo Luigi XVI e nella variegata scelta delle impiallacciature di essenze colorate sempre più spesso impreziosite con applicazioni di bronzi finemente cesellati e dorati come documentano, oltre agli arredi superstiti di Palazzo Pitti, anche un gruppo di incisioni eseguite da Giuseppe Landi durante i primi anni della Restaurazione.
Si trattava evidentemente di un gusto del tutto originale che, come ebbe a scrivere Giuseppe Vallardi nel 1831, non era ”né del moderno romano, né del milanese”, e che dovette far presa su Bezzuoli assiduo frequentatore dei cantieri di corte – nei quali era spesso chiamato ad intervenire con cicli di pitture, come ad esempio nel completamento della decorazione delle sale della Palazzina della Meridiana, avvenuto tra il 1833 e il 1837 - tanto da adottarlo per gli interni della sua residenza fiesolana, la villa in via di Fontelucente che passò in eredità al suo allievo prediletto, Demostene Macciò (Pistoia 1825 – Fiesole 1910). Quest’ultimo, oltre a conservare intatto l’arredamento voluto dal maestro, vi riunì molte delle sue opere acquistate via via negli anni con l’intento di tramandare ai posteri la memoria di un così insegne artista. Tutto l’insieme rimase intatto fino al 1966 quando la villa fu venduta, dopo essere passata in proprietà al figlio di Demostene, il notaio Emilio Macciò, e da questi lasciata in eredità a Gian Lauro Parri. In quella occasione parte dei suoi arredi furono trasferiti in un appartamento nel centro di Firenze, dove ebbi modo di vederli insieme ad altri oggetti appartenuti al pittore, dei quali Renata Parri, la madre di Gian Lauro, che nella villa aveva vissuto, mi illustrò la provenienza. Tra questi si possono citare un servizio di cucchiaini da caffè con le iniziali eseguiti dal noto argentiere fiorentino Guadagni, alcuni finali di aste per tende e una tenda ricamata facente parte di un più grande insieme di tendaggi che dovevano riquadrare le vedute di Firenze e delle colline circostanti che si potevano ammirare dalle finestre della villa.
Dalle descrizioni delle stanze riportate dalla signora Parri durante i miei incontri nella sua casa fiorentina e dal ricordo che di questi ambienti aveva ancora vivo Carlo Del Bravo, si può desumere che il loro assetto non doveva essere troppo dissimile da quello che ancora oggi si può notare in alcuni acquerelli raffiguranti gli interni abitati dai napoleonidi a Firenze durante la Restaurazione e pubblicati da Mario Praz nel suo volume La filosofia dell’arredamento. Soprattutto in quello raffigurante la famiglia Borghese nel palazzo di Borgo Pinti si nota come la sobrietà del mobilio, costituito dai semplici sedili in noce rivestiti da comode imbottiture, da una scrivania, da un parafuoco e da uno specchio posto sopra il camino, ben si accordava con i bianchi tendaggi che dalle pareti si sviluppavano fin sopra le finestre per finire intorno al baldacchino del letto, tutti dettagli in linea con la familiarità della scena raffigurante la principessa Adele de la Rochefoucauld Borghese festeggiata dai suoi tre figli. Un’intimità spesso presente nei ritratti di Giuseppe Bezzuoli che di quella società Biedermeier fu uno dei migliori interpreti.
Potremmo quindi pensare che lo scrittoio e il tavolino da centro appartenuti all’artista facessero parte di un arredamento simile a quello raffigurato nel citato acquerello e dove, all’interno di una stanza dalle pareti tinteggiate con colori dalle tenui tonalità pastello rischiarati dalla luce filtrata attraverso candide cortine abilmente drappeggiate su aste dorate, essi spiccavano per l’originalità delle forme e per il tono deciso delle loro impiallacciature in mogano, radica d’olmo e legno intagliato e dipinto. In particolare il modello del tavolo sorretto da un tronco di colonna da cui si diparte un cespo di stilizzate foglie di palma in legno tinto di verde e lumeggiato d’oro (lo stesso tipo di decorazione presente in uno dei finali di asta per tende raffigurante un ananas) potrebbe essere stato suggerito, quale tardivo omaggio alle mode settecentesche per l’esotismo, dal pittore stesso all’ebanista che lo realizzò tenendo presente le soluzioni decorative adottate da John Nash per il Royal Pavilion a Brighton dove le colonne della grande cucina terminano con capitelli a forma di foglie di banano, motivo, quest’ultimo, che ritroviamo anche in altri ambienti di quella residenza reale mescolato a draghi, uccelli esotici e fiori di loto.
Più vicino alle forme della mobilia Impero risulta essere invece lo scrittoio che, al centro del piano inclinabile del leggio rivestito in marocchino, presenta le iniziali “G B” riferite, come quelle che si vedono sui cucchiaini d’argento, all’artista. La forma leggermente bombata dei fianchi del mobile richiama quella realizzata dall’ebanista Giuseppe Colzi in un cassettone eseguito nel 1821 per la stanza da toilette nel Quartiere d’inverno di Palazzo Pitti insieme al bronzista Andrea Fondelli, incaricato dell’esecuzione delle applicazioni in bronzo dorato.
Tenendo conto che i mobilieri fiorentini, fin dagli inizi dell’Ottocento erano usi inserire nei loro arredi parti impiallacciate alternate ad altre in legno intagliato e successivamente tinto ad imitazione del bronzo, come si può vedere nel tavolino già nella villa di Giuseppe Bezzuoli, e della vicinanza stilistica dello scrittoio con la mobilia prodotta da Colzi, insieme a Fondelli, per la corte fiorentina, i due arredi qui illustrati rappresentano una significativa tappa dell’evoluzione del gusto toscano della Restaurazione sviluppatosi in quel particolare clima culturale dove, come scrive Carlo Del Bravo “riempire, non impiegare l’esistenza, produceva la straordinaria capacità di costituire ambienti, arredamenti, ove trascorrere una vita artistica, che, nel suo trascorrere, appunto e nella sua ferialità, doveva apparire più naturale (quindi più consona allo spirito del tempo) che l’immobilità distinta del monumento artistico”; una predisposizione estetica ed intellettuale che invitava dunque a circondandosi di “immagini di quell’ integrata natura” di cui anche il tavolino e i finali per tende dalle esotiche citazioni potevano essere un poetico esempio.
Enrico Colle
Nota bibliografica
I due arredi già in collezione Bezzuoli sono stati pubblicati in E. Colle, Il mobile Impero in Italia. Arredi e decorazioni d’interni dal 1800 al 1843, Milano 1998, pp. 150; 399, nn. 44c – 44d; per quanto riguarda i mobili di Colzi si rimanda a E. Colle, I mobili di Palazzo Pitti. Il secondo periodo lorenese 1800 – 1846. Il Granducato di Toscana, Firenze 2000 e, per la biografia dell’ebanista, al successivo volume, I mobili di Palazzo Pitti. Il secondo periodo lorenese 1800 – 1846. I ducati di Lucca, Parma e Modena, Firenze 2010, pp. 334 – 338. L’interno con la famiglia Borghese si trova illustrato in M. Praz, La filosofia dell’arredamento. I mutamenti del gusto della decorazione interna attraverso i secoli, Milano 1981, p. 213; mentre il brano di C. Del Bravo è stato tratto dal catalogo Disegni italiani del XIX secolo, Firenze, 1971, p. 12.
4di 5
Iscriviti alla newsletter di Orsini arte e libri
* campi obbligatori
Tratteremo i dati personali che hai fornito in conformità con la nostra informativa sulla privacy (che trovi linkata nel footer). Puoi annullare l'iscrizione o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sul link presente nelle nostre email.