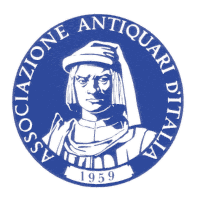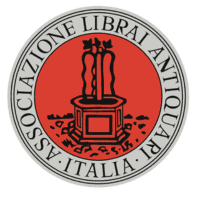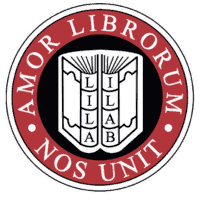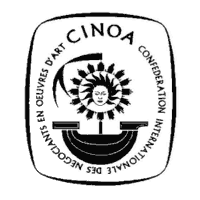Beretta
L’enigmatico Beretta, al quale non è stato ancora possibile associare un volto e tantomeno una storia, è a noi noto solamente per aver firmato questa allegra caricatura di Tommaso Minardi, che viene ritratto intento a delineare quella che sembra essere un’allegoria della Giustizia.
La presenza stessa di Beretta al fianco di Minardi e la precisa collocazione spazio-temporale del disegno, realizzato a Roma la sera del 7 dicembre 1815, come riporta l’iscrizione presente sul foglio, inducono a ritenere che il ritratto sia stato realizzato durante uno dei frequenti consessi serali in cui gli artisti si riunivano per dare vita a esercitazioni di gruppo fondate sul disegno, nelle modalità inaugurate da Felice Giani con la sua Accademia de’ Pensieri intorno al 1790 e confluite poi nell’esperienza dell’Accademia d’Italia, come documentato da Pelagio Palagi nell’opera intitolata La scuola di disegno del 1810 (Faenza, Pinacoteca Comunale).
Questa testimonianza così intima ed espressiva rivela che le riunioni diventavano l’occasione anche per consolidare “rapporti affettivi, quasi fraterni” (Leone 2009) tra gli artisti. Proprio Minardi, forse il più desideroso di “condividere le sue scelte di arte e di vita con altri giovani artisti allora a Roma” (Mazzocca 2018), era solito sublimare questi legami inserendo “trasfusi nei temi socratici, omerici e via dicendo […] i tratti fisionomici […] dei suoi maestri, del ristretto circolo delle amicizie. […] Al riguardo uno dei documenti più significativi è il grande e precoce disegno con Socrate e Alcibiade del 1807, dove compaiono in secondo piano i ritratti, a sinistra, del maestro Giuseppe Zauli, a destra, alle spalle del giovane Alcibiade, del condiscepolo Michele Sangiorgi e, con uno sguardo fisso e allucinato, l’autoritratto dello stesso Minardi, con quelle medesime fattezze che gli darà Hayez nel dignitario col berretto a tronco di cono rappresentato nel frammento della Morte di Abradate del 1813 - l’emblema visivo di un’amicizia intensa e artisticamente proficua nata nelle aule dell’Accademia d’Italia di Palazzo Venezia, che entrambi frequentano quali pensionanti” (Leone 2009).
“Dare a un personaggio le sembianze di una persona frequentata - spiega Fernando Mazzocca (2018) - rimanda all’abitudine, da parte dei pittori che, come Hayez o i Nazareni tedeschi, sono stati i protagonisti del delicato passaggio tra Neoclassicismo e Romanticismo, di ritrarsi a vicenda in immagini di gruppo che sono spesso un’orgogliosa dichiarazione nella lotta per un’arte nuova”.
MOSTRE
L’officina neoclassica. Dall’Accademia de’ Pensieri all’Accademia d’Italia. Faenza, Palazzo Milzetti, 15 marzo – 21 giugno 2009.
Literature
F. Leone, in L’officina neoclassica. Dall’Accademia de’ Pensieri all’Accademia d’Italia, catalogo della mostra, Cinisello Balsamo 2009, pp. 45, 78-79, 84 (fig.); F. Mazzocca, in Romanticismo, catalogo della mostra, Cinisello Balsamo 2018, pp. 244-245.Iscriviti alla newsletter di Orsini arte e libri
* campi obbligatori
Tratteremo i dati personali che hai fornito in conformità con la nostra informativa sulla privacy (che trovi linkata nel footer). Puoi annullare l'iscrizione o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sul link presente nelle nostre email.